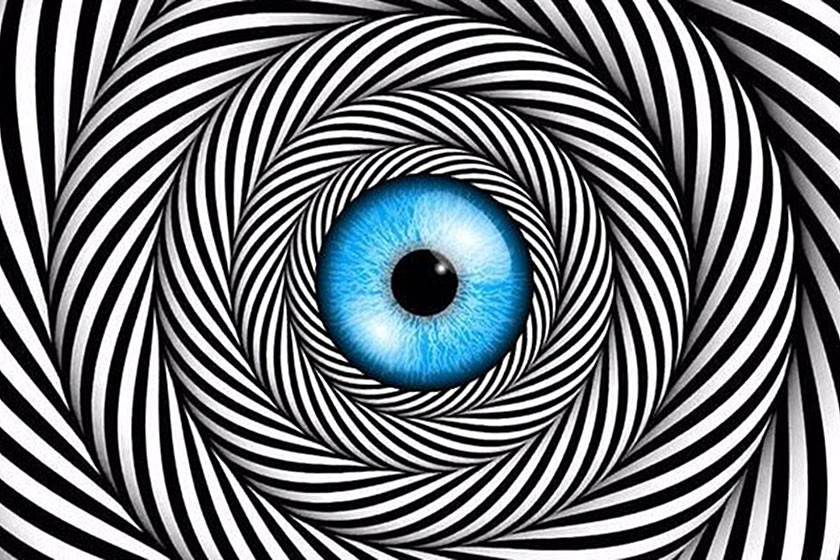Il Parco della Montagnola di Bologna, il più antico nonché l’ unico parco pubblico del centro cittadino, è attualmente oggetto di un intervento di riqualificazione che consiste nella ricostruzione del grande padiglione centrale, da sempre dedicato ad attività sociali e ricreative, collocato nell’area più utilizzata del giardino. L’intervento è stato approvato e avviato all’improvviso, senza alcuna consultazione pubblica dei cittadini che il Parco lo vivono né del Comitato Free Montagnola, che da anni promuove la qualificazione delle attività all’interno del giardino comunale, che sono stati interpellati solo a cose fatte in perfetto stile partecipativo alla bolognese. Davanti alle proteste dei cittadini e alla richiesta di interventi di manutenzione da tempo più urgenti e necessari, l’Amministrazione comunale è rimasta inamovibile, realizzando l’ennesimo esempio di manipolazione dei parametri – in questo caso di ‘consumo di suolo’- e degli strumenti amministrativi a vantaggio di politiche aggressive e impositive sul territorio e sui cittadini.
In questo articolo di Chiara Affronte, attivista del Comitato Free Montagnola, si parla di questa vicenda.
Il comitato Free Montagnola nasce per ‘restituire’ il parco ai cittadini e alle cittadine promuovendo attività all’ interno del Parco della Montagnola di Bologna
«Per consumo di suolo si intende qualsiasi tipo di copertura artificiale, ovvero qualsiasi suolo agricolo o naturale che viene convertito in infrastruttura; anche piazzali e cantieri, come indicato dal monitoraggio europeo».
Non ci sono dubbi per l’ingegnere Michele Munafò, ricercatore ad ISPRA – Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale commenta il report sul consumo di suolo in Italia (uscito in mezzo all’estate), da cui emerge che l’Emilia Romagna è terza per incremento annuale. Munafò chiarisce ulteriormente: «Il monitoraggio viene fatto con telecamere aeree che quindi fotografano ogni copertura, ogni estensione non naturale, ogni tettoia», spiega. Ecco perché anche l’edificio green progettato dall’architetto Mario Cucinella per il Comune di Bologna in Montagnola – che l’amministrazione insiste nel definire “verde”- consuma suolo, per l’Europa.
La petizione Non toccare il Verde
Lo sostengono da tempo i cittadini e le cittadine che hanno lanciato la petizione contro quella costruzione, convinti del fatto che i due milioni di euro stanziati per una struttura simile avrebbero dovuto essere utilizzati per la cura del parco, per arricchirlo di strutture innovative, inclusive e moderne, arredi e percorsi vita destinati all’attività all’aperto di persone appartenenti ad ogni fascia di età, adulti, anziani, adolescenti e bambini. Tuttavia, consapevoli del fatto che la cifra già impegnata è legata a risorse provenienti dal PNRR, chiedono con forza che si faccia il possibile per ripensare la decisione o che almeno l’edificio non superi le dimensioni della superficie sulla quale si trovava la vecchia tensostruttura: resti, quindi, nei 380 metri quadri e non arrivi ai 520 previsti dal progetto.

Una richiesta che ha un peso ancora più forte se si riflette sul cambiamento climatico in atto, per i firmatari della petizione che in poche settimane a giugno ha superato le mille firme. Perché – visto da quest’ottica – un edificio nuovo e più grande è in controtendenza rispetto alle emergenze attuali: «Rifiutiamo ogni logica di greenwashing; ingiustificabile il consumo di suolo in tempi in cui si dovrebbe aumentare il verde e non toglierlo», si legge nella petizione. Al suo interno si spiega chiaramente che «la Montagnola è il polmone di una zona della città che non ha altro verde disponibile: aumentare la superficie edificata per una struttura di cui oggi non si conosce la finalità concreta ci pare in controtendenza rispetto a ciò che l’Europa e l’emergenza ambientale richiedono».
Un edificio non è un prato!
L’Amministrazione, dal canto suo, continua – per l’appunto – a definire la struttura “verde”, adducendo come motivazione il fatto che buona parte dell’edificio non sarà effettivamente chiusa, ma sarà percorribile, attraversabile, perché costituita da sola tettoia e il terreno sottostante resterà permeabile. Ma permeabile non significa fruibile allo stesso modo di un prato: non sarà verde
Il fraintendimento normativo sul consumo di suolo
Il “fraintendimento” sorge dal fatto che non esiste una normativa nazionale. Inoltre, «nelle leggi regionali (nel caso delle Regioni che hanno normato su questo tema), sono previste molte deroghe -fa sapere ancora Munafò. Si sostiene, ad esempio, che le infrastrutture strategiche non debbano essere conteggiate nel consumo di suolo oppure che quanto viene fatto all’interno del tessuto urbano non è consumo di suolo, o che laddove gli strumenti urbanistici identifichino delle aree come edificabili, se poi in futuro si costruisce, quello, di nuovo, non è consumo di suolo perché era già consumato». Ma, chiarisce l’ingegnere di ISPRA: «Non si considera che, quando avviene la trasformazione, si crea un impatto ambientale, cioè consumo di suolo, appunto, per il nostro monitoraggio». Ecco perché «molti Comuni si trovano a seguire queste indicazioni che non sono proprio coerenti con la finalità di tutela di una risorsa ambientale, soprattutto non sono coerenti con le indicazioni di orientamenti europei».

Ma lo scontro con il Comune è anche su un piano più ampio: il cantiere è stato delimitato e chiuso in primavera e, nonostante i lavori si siano fermati ad aprile, l’area è rimasta recintata e non utilizzabile per tutta l’estate. Per il Comune “perché insicura”; ma i cittadini e le cittadine insistono nel sostenere che le poche buche, fatte per effettuare i carotaggi alla ricerca di eventuali ordigni bellici, avrebbero potuto essere coperte per poter rendere fruibile la zona nella calda stagione estiva, in attesa dei lavori previsti per l’autunno, e anche per poter manutenere il prato.
Un parco per chi?
Soprattutto, ciò che viene contestato con forza, è il progetto piovuto dall’alto, imposto, senza alcuna iniziativa di confronto con cittadini e cittadine.
Il “percorso partecipato” sulla Montagnola è arrivato, infatti, a progetto fatto e a petizione lanciata, come a «normalizzare» il dissenso, contestano i firmatari. Durante l’incontro con i cittadini, la Capo di Gabinetto Matilde Madrid (il primo cittadino era assente per indisposizione ndr) ha assicurato un impegno di 600mila euro sulverde
Resta per tanti cittadini e cittadine «la sproporzione tra le risorse investite “per il mattone” e quelle ipotizzate per ilverde